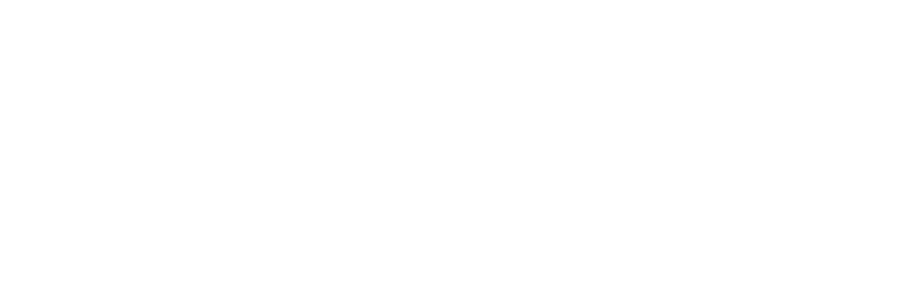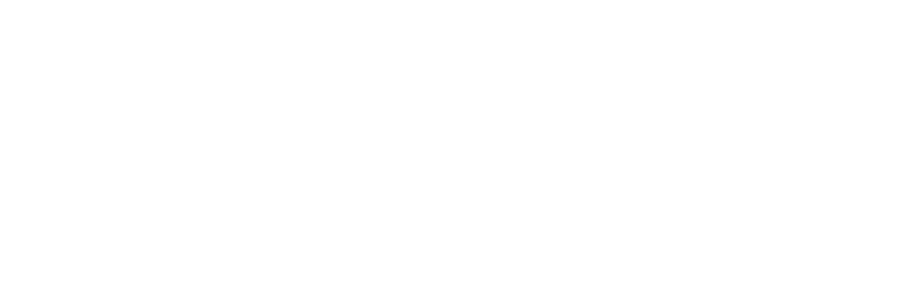Immaginate di essere immersi in un film d’azione. Il protagonista corre, salta, si getta da un palazzo in fiamme… e voi, seduti sul divano, sentite il cuore battere all’impazzata, i muscoli tesi come se foste voi a fare acrobazie da stuntman. Ma come mai? Siete lì fermi, magari con un sacchetto di patatine in mano! La risposta risiede in un fenomeno affascinante chiamato simulazione incarnata. Sembra fantascienza, ma è pura neuroscienza.
La simulazione incarnata è come un’incredibile performance teatrale che si svolge nel nostro cervello. Quando osserviamo un’azione, il nostro cervello la “recita” internamente, attivando le stesse aree che si accenderebbero se stessimo effettivamente compiendo quell’azione. Ma quali sono gli “attori” di questa rappresentazione mentale? il loro nome è “Neuroni Specchio”.
Avete presente quella sensazione di sete mentre guardate qualcuno bere un bel bicchiere d’acqua, magari ghiacciata, quando voi non avete nemmeno un goccio a portata di mano? Oppure quando vedete qualcuno scoppiare a ridere e sentite che vi scappa un sorriso, anche se non avete idea di cosa ci sia di divertente? Beh, potete ringraziare (o incolpare) i vostri neuroni specchio. Funzionano un po’ come un sistema di “realtà virtuale” personale e permanente. Come approfondito nel nostro articolo “Supernormal stimuli: la forza invisibile che condiziona le nostre scelte”, questo meccanismo ci rende particolarmente vulnerabili a certi tipi di stimoli. Solo che, a differenza della realtà virtuale, non potete toglierli come un visore: sono sempre lì, pronti ad attivarsi, in qualsiasi momento.
Pensateci: è un sistema che ci fa provare le cose “in prima persona” senza muovere un muscolo! Un film horror vi fa sobbalzare, una scena romantica vi scioglie il cuore e un video di gente che si allena in palestra… magari vi fa sentire persino un po’ stanchi!

L’esperimento di Pascual-Leone: il potere dell’immaginazione
Ma quanto è davvero potente questa simulazione cerebrale? Per capirlo, facciamo un viaggio indietro nel tempo, fino al 1992, quando il neuroscienziato Alvaro Pascual-Leone condusse un esperimento rivoluzionario.
Pascual-Leone mise insieme un gruppo di volontari e li divise in tre sottogruppi con un compito all’apparenza semplice: imparare una piccola sequenza di note al pianoforte. Ma attenzione, qui viene il bello. Il primo gruppo si esercitò davvero, con tanto di pianoforte, per due ore al giorno. Il secondo gruppo, beh, non fece nulla — probabilmente si sarà rilassato da qualche parte, forse pensando di essere finito nel gruppo più fortunato. E il terzo gruppo? A loro fu assegnato un compito particolare: dovevano osservare un video che mostrava qualcuno suonare la sequenza e praticare mentalmente i movimenti, senza mai toccare un tasto!
E così, giorno dopo giorno, questo terzo gruppo si trovava lì, occhi attenti al video, le dita che si muovevano a mezz’aria seguendo i movimenti sullo schermo, ma senza produrre alcun suono. Potreste immaginare cosa stessero pensando gli altri partecipanti, quelli che si allenavano davvero!
Eppure, alla fine dei cinque giorni, Pascual-Leone scoprì qualcosa di sorprendente: nel cervello di chi aveva solo praticato mentalmente osservando il video si erano verificati gli stessi cambiamenti neurologici di chi aveva fatto pratica vera. Praticamente, il cervello si era “allenato” grazie alla combinazione di osservazione e pratica mentale.
Questo risultato ha aperto le porte a un mondo nuovo: se il cervello può imparare così efficacemente dall’osservazione combinata con la pratica mentale, quante altre abilità potremmo sviluppare usando metodi simili? Forse, l’allenamento mentale fatto da Neo nel film Matrix, con un cavo attaccato dietro la testa, non è tanto lontano dalla realtà.
E se applicassimo il tutto alla visione di pornografia?
Se dunque l’immaginazione di suonare il pianoforte può cambiare il cervello, cosa succede quando osserviamo ripetutamente contenuti pornografici? Ebbene sì, proprio come quando “allenate” il cervello a fare musica senza pianoforte, il nostro cervello inizia a “praticare” anche qui, solo che stavolta non si tratta di Chopin.
Quando guardiamo pornografia, il cervello non si limita a osservare passivamente: partecipa, attiva i neuroni specchio e le aree del piacere, praticamente facendo una “jam session” di sensazioni come se stessimo vivendo quell’esperienza in prima persona. Ma cosa comporta tutto questo per la nostra mente?
Le implicazioni sono profonde e potenzialmente preoccupanti:
- Plasticità cerebrale Così come il gruppo di “pianisti immaginari” di Pascual-Leone ha modificato il proprio cervello, il consumo frequente di pornografia può plasmare i circuiti neurali legati alla sessualità. Più tempo passa sul “campo” (a.k.a. schermo) e più il cervello si adatta a quella forma di stimolo. (articolo su neuroplasticità)
- Aspettative irrealistiche Se il cervello passa molto tempo “praticando” scenari sessuali più vicini alla fantascienza che alla realtà, cosa succede quando si torna nel mondo reale? È un po’ come passare ore a guardare film d’azione e poi sperare di saltare da un tetto all’altro senza allenamento: non va mai come nei film. Questo allenamento mentale può alterare le aspettative e i comportamenti, rendendo la realtà… beh, un po’ meno “scenografica” e gratificante.
- Dipendenza potenziale Più il cervello simula queste esperienze intense e a portata di clic, più si rinforza il circuito del “ne voglio ancora!”. In effetti, la ripetizione continua di stimoli visivi intensi potrebbe spiegare perché alcune persone sviluppano comportamenti compulsivi legati alla pornografia. Praticamente, è come avere una playlist di piacere a portata di mano che il cervello non riesce a smettere di “riascoltare”.
- Desensibilizzazione Esattamente come il musicista ha bisogno di pezzi sempre più complessi per sentirsi stimolato, il cervello potrebbe iniziare a chiedere contenuti sempre più intensi. E qui si arriva a un punto delicato: la stimolazione costante può creare una sorta di “tolleranza”. Insomma, c’è il rischio che il cervello si abitui, richiedendo stimoli sempre più forti per provare la stessa intensità, fino, nei casi estremi, al desiderio di passare dall’immaginazione alla realtà scadendo tavoltà anche nell’illegalità, come descritto nel video qui sotto.
Quindi, la prossima volta che sentite la tentazione di fare un “allenamento” con contenuti espliciti, ricordate: il vostro cervello non sta solo guardando, ma anche “praticando” come un vero professionista. Magari è il caso di scegliere bene a cosa far “fare le prove” al nostro cervello, giusto per evitare che si convinca di dover ripetere lo spettacolo nella realtà! In fondo, quando si tratta di neuroni specchio, ogni scena può lasciare un segno.
Bibliografia
Per la simulazione incarnata e i neuroni specchio:
Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annual Review of Neuroscience, 27, 169-192.
Gallese, V., & Goldman, A. (1998). Mirror neurons and the simulation theory of mind-reading. Trends in Cognitive Sciences, 2(12), 493-501.
Per l’esperimento di Pascual-Leone:
Pascual-Leone, A., et al. (1995). Modulation of muscle responses evoked by transcranial magnetic stimulation during the acquisition of new fine motor skills. Journal of Neurophysiology, 74(3), 1037-1045.
Per la plasticità cerebrale in relazione al consumo di pornografia:
Kühn, S., & Gallinat, J. (2014). Brain structure and functional connectivity associated with pornography consumption: The brain on porn. JAMA Psychiatry, 71(7), 827-834.
Per gli effetti potenziali del consumo di pornografia sulle aspettative e i comportamenti:
Wright, P. J., Tokunaga, R. S., & Kraus, A. (2016). A meta-analysis of pornography consumption and actual acts of sexual aggression in general population studies. Journal of Communication, 66(1), 183-205.
Per la potenziale dipendenza e comportamenti compulsivi:
Love, T., et al. (2015). Neuroscience of Internet Pornography Addiction: A Review and Update. Behavioral Sciences, 5(3), 388-433.
Per la desensibilizzazione e l’escalation:
Wéry, A., & Billieux, J. (2016). Online sexual activities: An exploratory study of problematic and non-problematic usage patterns in a sample of men. Computers in Human Behavior, 56, 257-266.